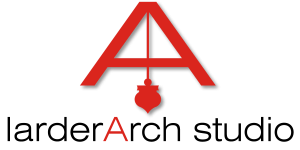L’incarico prevedeva inizialmente, per la mostra, l’utilizzo di due spazi espositivi: la sala Gian Ferrari, un residuo architettonico della caserma preesistente, situata al piano terreno in corrispondenza dell’atrio d’ingresso e la vasta Galleria 5 con la grande vetrata inclinata e situata al secondo piano. Due spazi distanti fra loro circa 130 metri. E’ stato quindi necessario creare un collegamento non solo ideale con gli spazi, punteggiando tutto il percorso di opere. L’ordinamento delle opere allestite è talmente fluido che scorre dall’esterno all’interno senza soluzione di continuità occupando gli spazi più rappresentativi del museo. La mostra non è quindi costruita per punti chiave ma fluisce circolarmente tanto che il visitatore, più che percorrere gli spazi architettonici del museo, è come immerso nel suo fluido quasi fosse un subacqueo che esplora una gigantesca e aliena arca sommersa.
Gli spazi della mostra si possono riassumere in 4 zone: l’esterno, l’atrio con il corpo scale, la sala Gian Ferrari e la Galleria 5.
Accoglie il visitatore l’opera più urbana di GDD, il gigantesco scheletro di 24 metri (Calamita cosmica, 1989). Fin dal primo sopralluogo ho subito immaginato la grande opera in quella posizione: uno spazio coperto di fronte agli ingressi principali, che sembrava concepito appositamente per accogliere il fossile umano, affascinante come un dinosauro preistorico.
Le finestre lo avvolgono completamente: sia le grandi vetrate del piano terreno che quelle della Suite 3 e del ponte di collegamento. La copertura aggettante in pesante calcestruzzo sovrasta il corpo come un sarcofago megalitico, sotto di esso si inserisce perfettamente anche l’asta dorata. Per migliorare l’installazione ho elaborato una tecnica specifica con la quale è stato possibile nascondere ogni sistema di appendimento e stabilizzazione dell’asta. Tale tecnica si avvale dell’uso di fili intrecciati in fibra Kevlar, in grado di sostenere carichi elevati con uno spessore inferiore al millimetro e con una deformazione elastica infinitesima.
Varcata la vetrata d’ingresso, poggiata direttamente sul candido pavimento, si incontra subito la Mozzarella in carrozza che dialoga con l’immenso vuoto dell’atrio attraversato da oscuri canali di flusso ascensionale (il corpo scale) e dalle saette luminose di Maurizio Mochetti (Linee rette di luce nell’iperspazio curvilineo).
La carrozza anticipa la sala dove sono raccolte le opere più concettuali. La sala Gian Ferrari, è stata completamente trasformata, un insieme di contropareti e setti genera uno spazio essenziale, bianco, che vuole rievocare lo spazio della galleria L’attico nel garage underground di Fabio Sargentini. Ma la presenza delle quattro colonne in ghisa, della storica caserma preesistente, ha evocato anche altri riferimenti: l’interesse di De Dominicis per i sumeri e il mito di Gilgamesh, monarca-architetto di Uruk, per due terzi divino e per un terzo umano.
La planimetria della sala viene geometrizzata idealmente sul modello dei templi dissepolti di Uruk creando un gioco di suggestioni in cui anche le colonne in ghisa si rapportano ai fasci in giunco delle capanne arabe della Mesopotamia inferiore.
La sala concettuale: L’attico-Uruk diviene anche il tempio terrestre da dove i visitatori-iniziati intraprendono l’ascesa verso il tempio cosmico della sala dorata dei pianeti.
Da questo momento in poi il percorso espositivo è tutta un’ascesa, un vero percorso iniziatico con il grande atrio-caverna disseminato di apparizioni mostruose e demoniache: la nota serie dei Diavoli. Per rendere il tragitto ancora più inquietante, un’idea di Achille Bonito Oliva, si diffonde echeggiando la grassa risata di De Dominicis, registrazione audio ripetuta ad anello legata all’opera D’io (1971). Questa risata è il vero collante acustico che si diffonde rimbalzando per tutto l’atrio d’ingresso.
Ci si avventura verso la Galleria 5 scalando la rampa nastriforme. La parete sinuosa dell’antro è, ad ogni stazione, allestita con opere adagiate su pannelli espositivi che appaiono fluttuanti. Il visitatore è sollecitato da innumerevoli prospettive inattese. La percezione è avvolgente e le creature dipinte, con i loro grandi becchi, appaiono aggrappate alle pareti come fossero Arpie, i mostruosi uccelli del lago Stinfalo sconfitte da Ercole.
Il grande vuoto dell’atrio ha una superficie di 534 mq per 16 metri di altezza. Non è mai stato concepito da Zaha Hadid come spazio espositivo al di là del concorso del 2% vinto dall’opera già citata di Maurizio Mochetti.
Per poter ottenere quest’effetto, di grande impatto scenografico, naturalmente non è stato possibile perforare a piacimento la pelle cementizia, si è dovuto elaborare un sistema di ancoraggio completamente rimovibile in grado di sfruttare le tipiche forature che rimangono impresse nel calcestruzzo dai tiranti delle casseforme metalliche. I pannelli espositivi, distanziati di alcuni centimetri dalla superficie del museo, una volta conclusa la mostra si smontano lasciando la superficie di ancoraggio completamente integra.
Lungo il percorso, al secondo piano, si incontra una fila di cubo-teche anch’esse completamente sospese lungo il setto centrale in calcestruzzo. Queste teche, illuminate autonomamente, proteggono come preziosi tabernacoli le opere più piccole.
Di fronte, sulla parete bianca del museo, nel punto in cui la rampa genera una grande ansa circolare, una proiezione video documenta con interventi ed interviste il lavoro dell’autore evocato come una presenza concreta.
Dopo la pausa video il percorso, che si insinua fra le pieghe dei tracciati hadidiani cementificati, si fa più sereno ed è ancora punteggiato di opere, come le due Opera ubiqua (1997). La rampa metallica come un serpente ormai domato ci dirige verso il portale della Galleria 5: l’ingresso al tempio stellare che, come la porta del sole del tempio di Salomone, separa le tenebre dalla luce.
Varcato l’ingresso ci accolgono misteriosi sacerdoti alieni (figure ieratiche tridimensionali mai esposte dall’artista) che come guardie del tempio celeste controllano, severi e silenziosi, il nostro percorso espositivo-iniziatico. Questa è l’ultima tensione architettonico-iconografica. La struttura espositiva si innesta eugeneticamente nel DNA compositivo della sala. L’impressione è quella di attraversare il collo di una clessidra, tutto lo spazio è fortemente curvato, il lucernario, le fessure nastriformi luminose (radiazione di fondo del segno hadidiano), l’architettura espositiva del tempio e anche la superficie del pavimento (sensibilmente in salita) ci ricorda che il percorso artistico-spirituale non è ancora concluso.
Dal collo della “clessidra” fuoriesce un setto di spina che rievoca idealmente il percorso nastriforme delle rampe. È l’asse portante del complesso espositivo, una strada ascendente che conduce alla sala dei pianeti e all’asta d’oro. Tutta la geometria del “campo” scorre lungo il flusso dei tracciati generatori, “naturalmente, un museo progettato come un campo non è un modo di esporre l’arte, ma in questo campo si possono sistemare pareti provvisorie perpendicolari a quelle del perimetro principale.” (Z.H.) E’ in quest’ottica che si sono generati i setti perpendicolari al flusso: generato dall’urbanistica del sito, dopo innumerevoli vortici architettonici varca l’immensa vetrata e si rituffa, come se fosse una fragorosa cascata, nel serbatoio urbano romano.
I setti perpendicolari, per quanto necessari, sono geometricamente generati dalle onde armoniche determinate dal volume tecnico delle scale e dell’elevatore come se si trattasse di un grosso masso squadrato in mezzo al fiume. Ricorda l’opera di De Dominicis dove il Tentativo di far formare dei quadrati invece che dei cerchi attorno ad un sasso che cade nell’acqua (1969) in questo caso invece riesce. Dal grosso parallelepipedo, alimentati dalla corrente fluida del setto centrale, si staccano vibranti setti perpendicolari con intervallo armonico. La forma definitiva della maglia progettuale, con stanze e nicchie espositive, è così generata dalla sovrapposizione di queste “onde” che possiamo dire ritagliate dai percorsi di scorrimento verso la grande vetrata e dalle aperture longitudinali dei lucernari sul soffitto.
Tutti gli spazi residuali (corridoi) sono allestiti con frasi estratte da scritti e interviste dell’artista. Si crea così un secondo spazio, parallelo e nascosto dietro i setti espositivi che sostengono le opere; uno spazio non visivo ma puramente teorico.
La sala dei pianeti è l’apice della mostra: “luogo astrale e siderale in cui si combattono gli elementi.” (A.B.O.)
La sala ha una valenza sacra, la luce che proviene dalla grande finestra sull’universo illumina le tavole su fondo d’oro. L’atmosfera è rarefatta, unico oggetto della sala l’asta dorata che vibra in eterno equilibrio. Questa è la fine e l’inizio della mostra.
(P.S.) – Patrik Schumacher, MAXXI, Zaha Hadid Architects. Skira, 2010.
(J.G.) – Joseph Giovannini, MAXXI, Zaha Hadid Architects. Skira, 2010.
(A.B.O.) – Achille Bonito Oliva, Catalogo della mostra: Gino De Dominicis, l’immortale. Electa, 2010.
(M.D.) – Massimo Donà, Catalogo della mostra: Gino De Dominicis, l’immortale. Electa, 2010.
(Z.H.) – Zaha Hadid, MAXXI, Zaha Hadid Architects. Skira, 2010.
Federico Lardera, aprile 2011